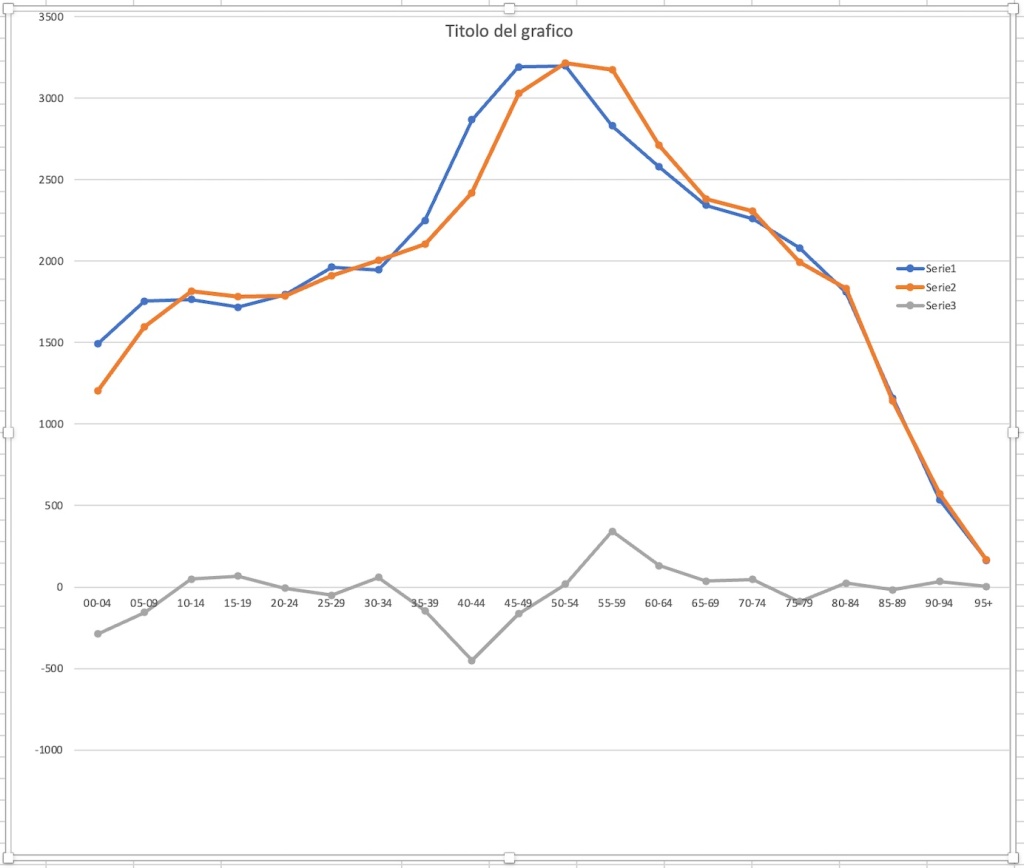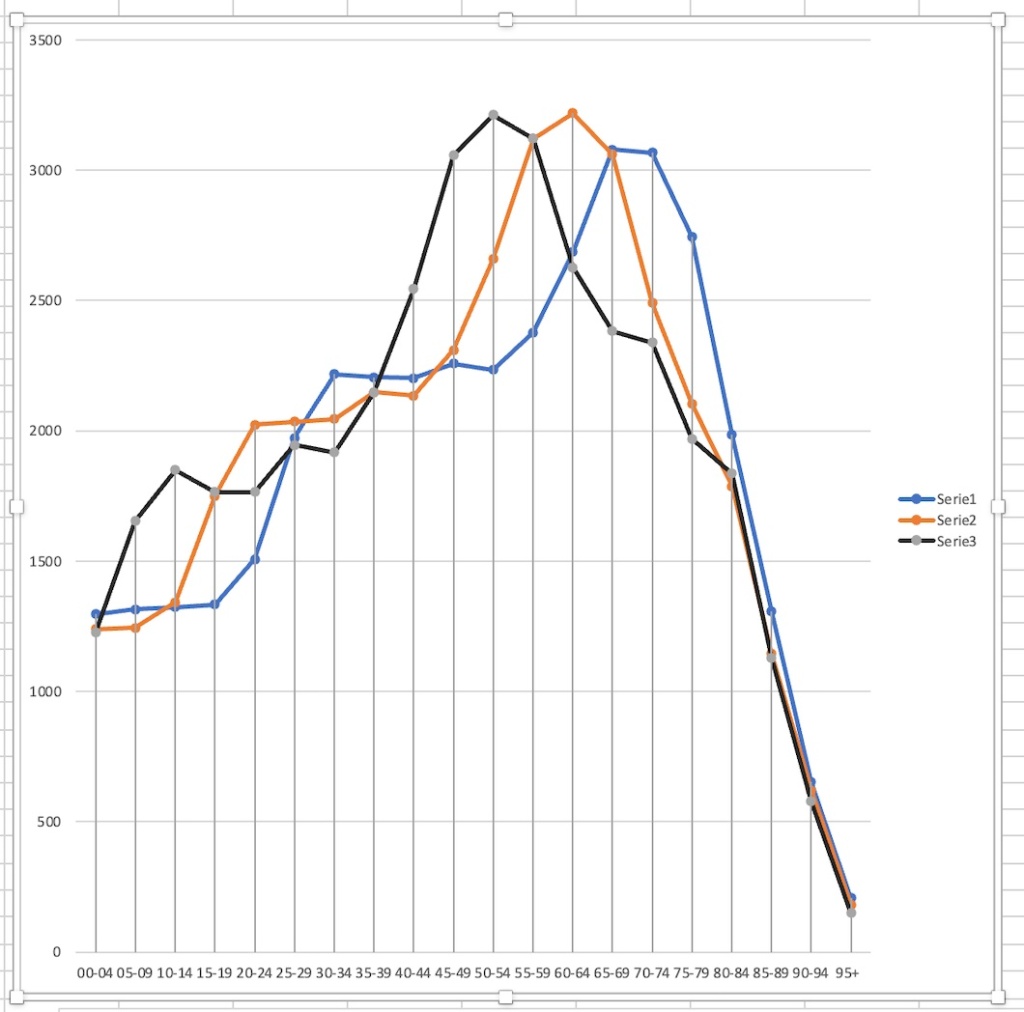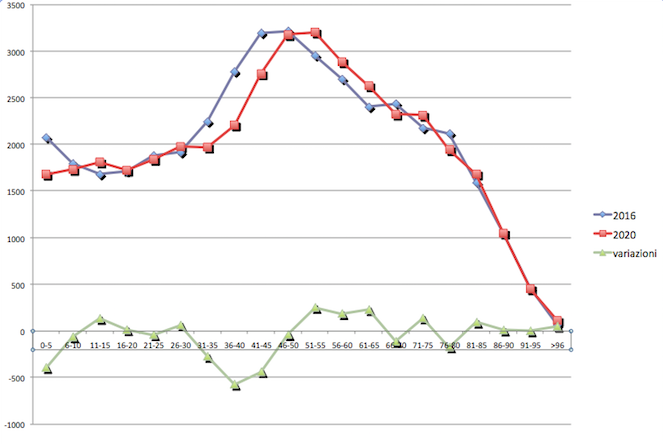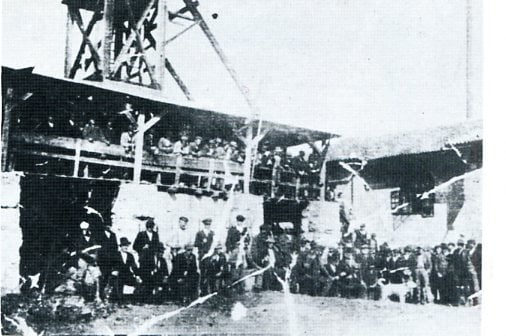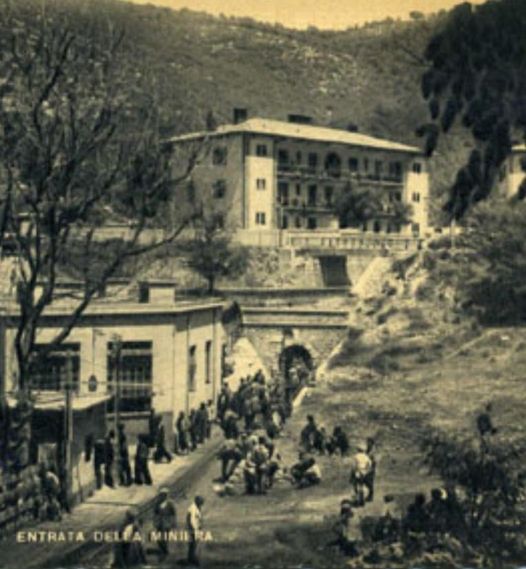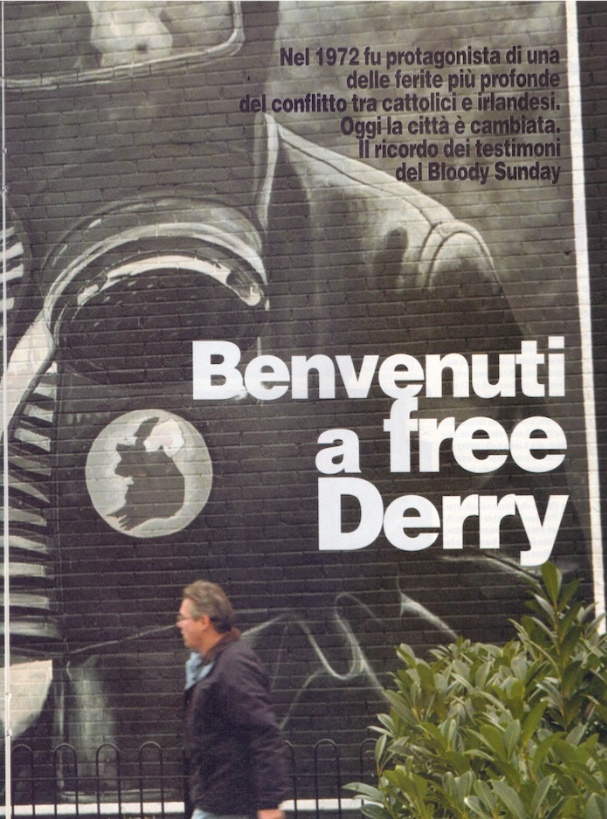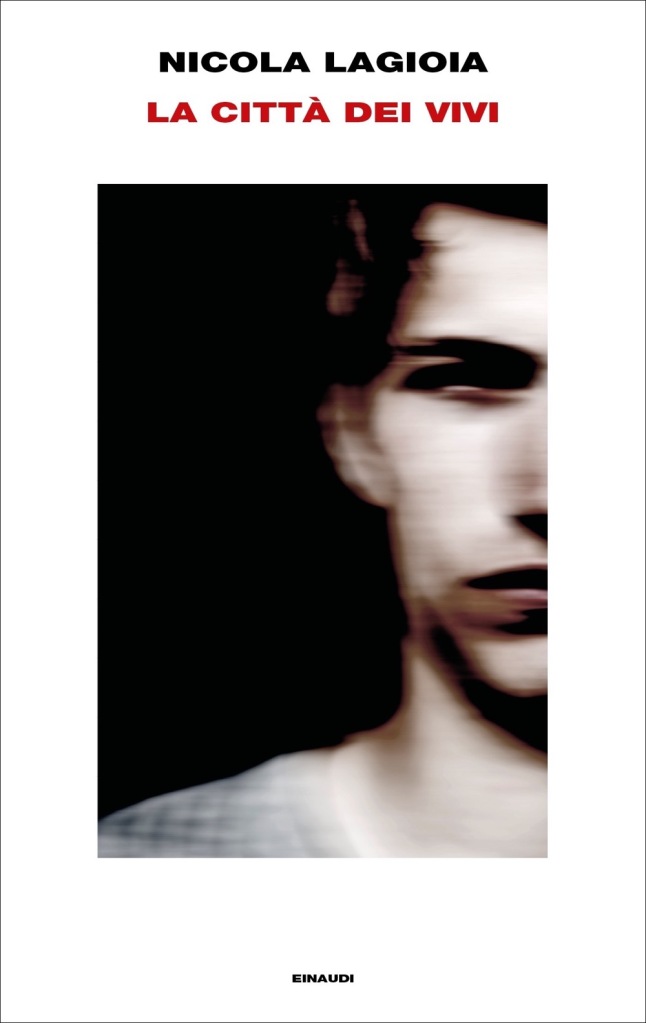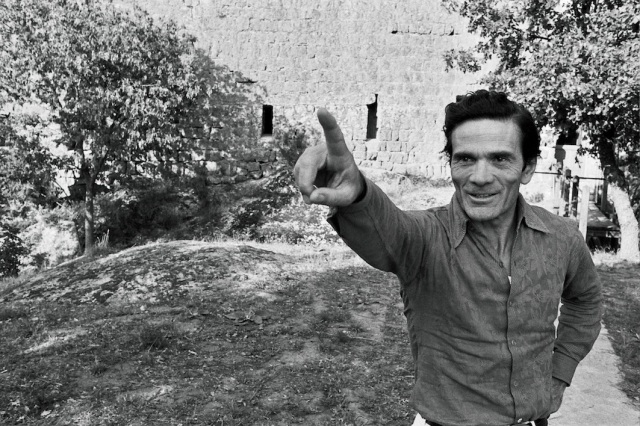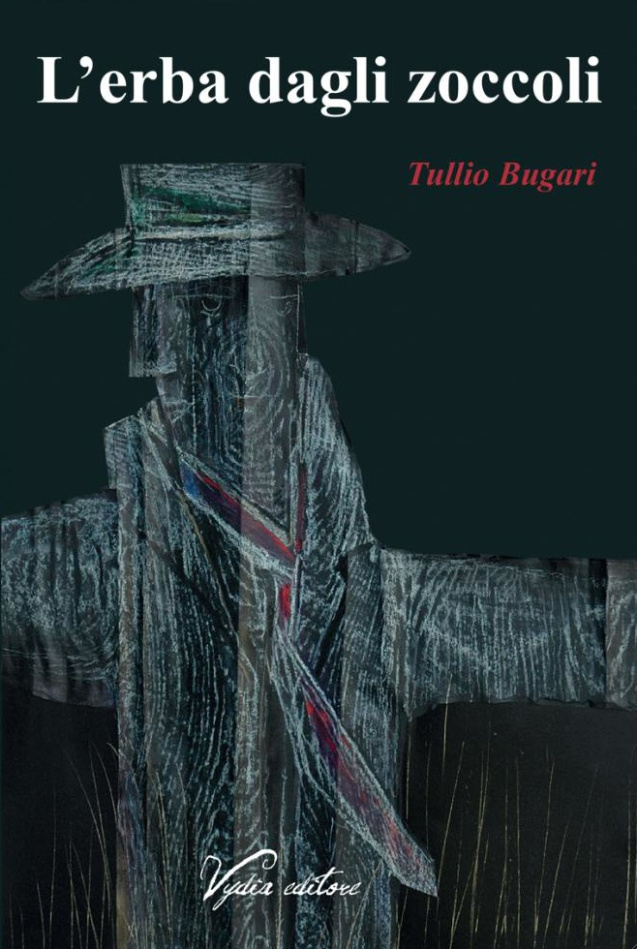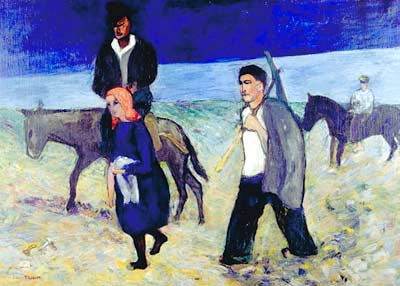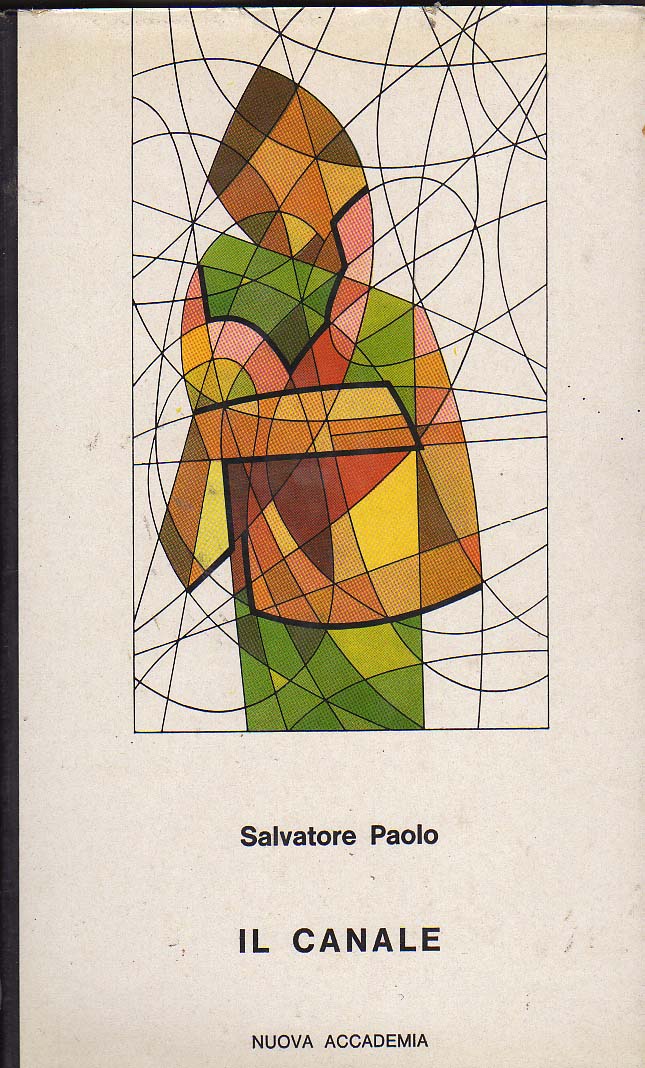Essaouira. Appunti molto vari di viaggio. Andavamo soltanto a un festival musicale, e invece… Gnaoua, come leggo da un articolo che dovrebbe mettermi in guardia da pigrizie turistiche, si riferisce tanto alla musica quanto alle confraternite maghrebine custodi di una tradizione che ha origine nell’Africa centrale e occidentale, e arriva qui rivissuta dai discendenti di differenti gruppi etnici – Haussa, Fulani Bambara e altri – che hanno condiviso la condizione dell’esilio e l’esperienza della schiavitù. Il Marocco era l’ultima tappa di un viaggio che avrebbe dovuto condurli, come tanti altri, in Europa o nel nuovo mondo come schiavi, e schiavi lo erano già diventati prima ancora di arrivare qui.
Essaouira. Appunti molto vari di viaggio. Andavamo soltanto a un festival musicale, e invece… Gnaoua, come leggo da un articolo che dovrebbe mettermi in guardia da pigrizie turistiche, si riferisce tanto alla musica quanto alle confraternite maghrebine custodi di una tradizione che ha origine nell’Africa centrale e occidentale, e arriva qui rivissuta dai discendenti di differenti gruppi etnici – Haussa, Fulani Bambara e altri – che hanno condiviso la condizione dell’esilio e l’esperienza della schiavitù. Il Marocco era l’ultima tappa di un viaggio che avrebbe dovuto condurli, come tanti altri, in Europa o nel nuovo mondo come schiavi, e schiavi lo erano già diventati prima ancora di arrivare qui.
È questo che leggo da alcuni articoli trovati curiosando in rete, tra testi di musica e di antropologia, mentre inizio a immergermi nella vivacità del festival, e anche di questa cittadina, Essaouira, posta in faccia all’Atlantico come una sfida. Antichissima, fu fondata, mi pare, addirittura dai fenici, e in epoca moderna i primi europei che vi arrivarono furono i portoghesi. Viaggiatori di mare. Abitata a lungo da una consistente comunità ebraica, che pochi decenni fa costituiva la maggioranza. Tanti volti diversi fusi insieme.
Ci siamo avvicinati (quando parlo al plurale intendo il nostro gruppo di otto persone, assortite e intergenerazionali, riusciamo a coprire una gamma ampia di età, e varie curiosità) passando da Marrakech la rossa, colorata di materia e densa come le sue calde terre, e quindi il frastuono delle percezioni era già innescato dentro di noi prima ancora dell’arrivo qui.
Essaouira ci appare subito come avvolta nei suoi stessi vicoli, con una freschezza che sa di immediato, battuta dal mare e dal vento, e i colori bianchi azzurri o blu quasi provenzali o greci, come di un’idea di Mediterraneo che si prolunga, o di un Africa che è già un ponte oltre se stessa.
Essaouira la bianca, o la blu, satura di cielo, di vento e di mare, dai mille angoli e volti, incubatrice di tante piccole storie se solo si avesse il tempo, o il modo, di coglierne davvero qualcuna.

 Essaouira la città degli alisei ci accoglie ventosa, anche troppo in questi giorni, il vento è davvero eccessivo ci dicono anche gli abitanti di qui, come animato da una qualche eccitazione particolare, o dispettosa, a tratti addirittura freddo o fastidioso, ma nessuno si scoraggia o rinuncia a farsi colpire la pelle da questa aria lanciata attraverso i deserti e i monti, pronta a tuffarsi nell’oceano, mentre i vicoli ci proteggono e ci conducono in angoli che sanno di calma e di piccole cose.
Essaouira la città degli alisei ci accoglie ventosa, anche troppo in questi giorni, il vento è davvero eccessivo ci dicono anche gli abitanti di qui, come animato da una qualche eccitazione particolare, o dispettosa, a tratti addirittura freddo o fastidioso, ma nessuno si scoraggia o rinuncia a farsi colpire la pelle da questa aria lanciata attraverso i deserti e i monti, pronta a tuffarsi nell’oceano, mentre i vicoli ci proteggono e ci conducono in angoli che sanno di calma e di piccole cose.
Essaouira è anche la città dei gatti, come il titolo di un libro dell’antropologa Anna Maria Rivera, una che le ha trovate le piccole storie a cui alludevo, perché è andata a cercarle, e poi nel suo libro le racconta nella forma di un’antropologia animalista della città, restituendoci di queste storie il ritratto del rapporto di tolleranza e compassione che i suoi cittadini, come scrive lei stessa parlando soprattutto dei più poveri e disagiati, instaurano con i tantissimi gatti (ma anche cani e gabbiani) che abitano tra questi vicoli, concedendosi il lusso di un maternage verso questi altri viventi che sono gli animali. E così, continua la Rivera, le persone più povere si sottraggono alla ragione economica e utilitaria che le ha condannate, e spezzano la catena dell’obbligata dipendenza dal bisogno cui la società le ha legate e le immagina schiave. Riconquistano il loro spazio di autonomia e dignità. Anche questo è il contesto del festival che ci accoglie. Sono davvero tanti i gatti che vivono in simbiosi con l’anima della città. Li vedi ovunque, tranquilli e sonnacchiosi, un po’ ruffiani come sanno fare soltanto loro, che entrano nei negozi, si coricano in un angolo, si strusciano, mentre attorno da ogni angolo ti arriva il suono forte o soffuso di questa musica altrettanto immediata e fresca, di cui non riesci a indovinare il confine tra tradizione e innovazione.

 La musica Gnaoua si è anche modernizzata, come viene detto usando questa parola forse in un modo che la fa sembrare capace di snaturare un delicato equilibrio. Che vorrà dire modernizzarsi? Non riesco a comprenderlo del tutto, conosco poco di ciò che ho davanti, mi arrampico quasi sugli specchi con le poche nozioni che ho raccattato e con quel poco che afferro guardando o ascoltando.
La musica Gnaoua si è anche modernizzata, come viene detto usando questa parola forse in un modo che la fa sembrare capace di snaturare un delicato equilibrio. Che vorrà dire modernizzarsi? Non riesco a comprenderlo del tutto, conosco poco di ciò che ho davanti, mi arrampico quasi sugli specchi con le poche nozioni che ho raccattato e con quel poco che afferro guardando o ascoltando.
Mi viene in mente, in Italia, la musica Salentina, e la pizzica, con la sua origine ancestrale che affonda forse addirittura nella Magna Grecia, o nella religiosità popolare, nel senso non di esclusivo del popolo ma di tutti i giorni, e nel senso della sua capacità di guarigione dal rimorso che riemerge, purché la musica sia eseguita all’interno di un rituale consolidato e socialmente condiviso, deve essere coreutica, con i suoi canti e controcanti, e mirata, ciascuna capace del linguaggio specifico adatto a ogni singola situazione, accompagnandosi al suo colore.
Gli ultimi residui resistenti li ha studiati l’antropologo Ernesto De Martino alla fine degli anni Cinquanta, gli stessi anni delle occupazioni delle terre, capaci di sconfinare nel mito come le occupazioni d’Arneo, quando si consumavano una a fianco dell’altra le ultime resistenze di una civiltà contadina che si voleva giunta al capolinea, accerchiata e allo stremo. Contadini costretti da lì a poco a emigrare, loro malgrado. Resistenti non per un attaccamento particolare alla tradizione, anzi, credo che anche quei contadini avessero voluto la modernità, purché più equa dell’iniqua tradizione che a loro era toccata in sorte. Dopo De Martino in pochi si avventurano ancora, ma non mancano, sulle tracce della religiosità popolare nostrana, e insieme a questa delle nuove fatiche di oggi, dei nuovi braccianti giunti proprio dall’Africa a riempire i vuoti lasciati da quelli andati via ieri.
E la musica? La musica è come una memoria che ha raccolto, incubato e traghettato oltre, oltre un rimorso che ci sembra soltanto di avere addomesticato e invece dev’essere ancora vivo in noi, da qualche parte. Oggi è diventata la musica di quello che viene chiamato anche neo tarantismo, la nuova musica che ad ascoltarla talvolta sembra ancora una magia, e che intanto ha conquistato il mondo, la pizzica di oggi che sembra oramai affrancata del tutto da qualsiasi residuo di arcaica religiosità e di bisogno di guarigione, e dunque sembra altro, possiamo farne anche consumo, tutto si misura oramai sul mercato. Chissà? Penso che mai nulla del sentimento umano possa essere davvero del tutto controllato o dimenticato, ma non so nemmeno cosa traspare e in che modo, o tutto magari dipende soltanto dalle capacità di scavo dei nostri sguardi odierni, che non sempre reggono il passo. Dobbiamo continuare a imparare, questo è certo, o imparare di nuovo come ci si orienta.

 Anche qui a Essaoira con gli Gnaoua, che vengono identificati anche come etnia, così come è avvenuto per i Bambara, i Dogon e altre popolazioni più a sud, non sono mancate le attenzioni degli antropologi, venuti qui forse proprio nel momento dell’ultimo cambiamento, per porre in tempo le basi dell’etnopsichiatria e di una nuova attenzione alle forme di guarigione sciamaniche, che si basano su dispositivi diversi da quelli elaborati dal pensiero e dalla medicina europea. Dispositivi terapeutici che insistono di più sulle relazioni sociali della collettività e del gruppo, che non sull’individuo isolato. Se lo isoli lo spezzetti e lo metti sotto cura, se lo reintegri nella comunità è la comunità che cura se stessa e l’individuo lo rendi di nuovo intero. Più o meno. Sono un profano e ho in testa nozioni approssimative, che derivano da vecchie letture di Tobie Nathan o dei nostri Piero Coppo o Roberto Beneduce, quando anni fa iniziai a interessarmi non proprio di terapie della guarigione ma di intercultura, che forse può essere definita una terapia di guarigione sociale, per non disintegrarci, ma alla quale in molti ottusamente resistono. Tutto qui. Ma forse anche questi studi antropologici a cui accenno hanno avuto la loro evoluzione, non ne conosco gli eventuali aggiornamenti. La tradizione e la modernità.
Anche qui a Essaoira con gli Gnaoua, che vengono identificati anche come etnia, così come è avvenuto per i Bambara, i Dogon e altre popolazioni più a sud, non sono mancate le attenzioni degli antropologi, venuti qui forse proprio nel momento dell’ultimo cambiamento, per porre in tempo le basi dell’etnopsichiatria e di una nuova attenzione alle forme di guarigione sciamaniche, che si basano su dispositivi diversi da quelli elaborati dal pensiero e dalla medicina europea. Dispositivi terapeutici che insistono di più sulle relazioni sociali della collettività e del gruppo, che non sull’individuo isolato. Se lo isoli lo spezzetti e lo metti sotto cura, se lo reintegri nella comunità è la comunità che cura se stessa e l’individuo lo rendi di nuovo intero. Più o meno. Sono un profano e ho in testa nozioni approssimative, che derivano da vecchie letture di Tobie Nathan o dei nostri Piero Coppo o Roberto Beneduce, quando anni fa iniziai a interessarmi non proprio di terapie della guarigione ma di intercultura, che forse può essere definita una terapia di guarigione sociale, per non disintegrarci, ma alla quale in molti ottusamente resistono. Tutto qui. Ma forse anche questi studi antropologici a cui accenno hanno avuto la loro evoluzione, non ne conosco gli eventuali aggiornamenti. La tradizione e la modernità.
Anche la musica Gnaoua a partire dagli anni Settanta, mi pare, si è modernizzata e in seguito ha conquistato il mondo, e il mondo oggi è qui, dentro questo festival internazionale arrivato alla edizione numero 19. La sua fondatrice, leggo, è una donna, aspetta a lei questo mito delle origini del festival, si chiama Neila Tazi. Leggo una sua intervista di pochi giorni fa. Quando le chiedono: “Come avete sperimentato lo sviluppo del Festival? Potevi immaginare tale successo 20 anni fa?”, lei risponde: “Uno scienziato francese una volta ha dichiarato: l’evoluzione è un evento-based, è l’evento che causa l’evoluzione a verificarsi e l’evento porta alla trasformazione. Sapevamo che era una idea di alto profilo, anche se in via preliminare pochissimi ci credevano. E ha richiesto un sacco di lavoro, una visione vera e trasmessa da media marocchini e stranieri, un impatto economico indiscutibile e ultimo, un enorme entusiasmo popolare che ha fatto diventare il Festival uno sforzo serio.” E più avanti, rispondendo a un altra domanda, aggiunge: “Essaouira, una città lontana dai riflettori, come lo erano gli Gnaoua dei quali abbiamo avuto un’immagine riduttiva. Soprattutto perché per un tempo troppo lungo l’azione culturale non è stata presa in considerazione come una vera e propria leva di sviluppo e di potere…. Oggi possiamo vedere che la cultura nell’azione pubblica di piccole città può essere un catalizzatore di politiche urbane e della ristrutturazione territoriale. La cultura è un progetto politico vero e proprio! Deve essere profondamente integrato e in modo trasversale, svolge un ruolo nella formazione, il turismo, la diplomazia e la comunicazione!”
Forse anche la modernizzazione ha mille volti, da scrutare e anche apprezzare ogni tanto, senza essere sbrigativi? Qual è il suo rapporto con la tradizione? La cultura non si mangia diceva invece qualcuno da noi.
Continua Neila Tazi: “Per evolversi è necessario cercare di realizzare qualcosa che va al di là di ciò che è già stato raggiunto. È proprio quello stato d’animo che governa il nostro modo di gestire e pensiamo di questo festival. Ogni edizione deve essere più intensa che la precedente, dobbiamo perseverare la nostra capacità di sorprendere e stimolare la curiosità del pubblico, al fine di ottenere la sua fedeltà. Non è più difficile, ma, preferisco dire che è altrettanto difficile. Alcune cose si muovono in avanti, all’indietro altre … Noi continueremo a combattere (…) è uno sforzo che richiede investimenti, professionalità e una pianificazione efficace. Troppe persone pensano ancora che la cultura è una questione semplice che può essere improvvisata… mentre richiede visione e la necessità di finalizzare il progetto da molto tempo in anticipo se vogliamo fornire un lavoro di qualità.”
La cultura, se non si mangia, nemmeno si improvvisa. Penso a noi nel nostro paese, dove cresce sempre di più il numero delle persone che non sanno più improvvisare nemmeno se stesse. Neila Tazi si sta impegnando per registrare Gnaoua e la sua musica sulla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
La musica e i suoi strumenti. Il guenbrì, i crotali e i tamburi. La musicalità del guenbrì, tesa ed elegante come una carezza che si insinua, penetra e si ripete, ripete i suoi cicli, li rivive; i crotali, sonagli di ferro e legno che scandiscono una vibrazione ritmica che sale su dalla terra e ti entra nella testa; i tamburi che ti guidano il passo, e forse noi stessi siamo casse di risonanza che palpitiamo in questo cammino. Il guembrì è al tempo stesso strumento a corda e a percussione, è della famiglia dei liuti, con una forma particolare, un manico che sembra un bastone e una cassa armonica che sembra una scatola allungata, di sessanta per venti per quindici. Dovrebbe essere di legno di pioppo, mi pare, e non deve essere mai lasciato incustodito o in luoghi non adatti per non far infuriare i mlūk, gli spiriti.
 Leggo così, in fretta, avido di pormi domande e curiosità che se vorrò poi davvero soddisfare, dovrò lasciarmi guidare dalla pazienza e dalla calma. L’origine della musica, degli strumenti, dei suoni, rinvia alla particolare e complessa ritualità sciamanica Gnaoua, di cui è parte integrante. I rituali di possessione e guarigione, la lunga notte, la Lila, che fa da incubatrice, dove tutto avviene, riemerge insieme e insieme i partecipanti si compenetrano. Non so quasi nulla di queste cose, cerco di registrare indizi che mi spieghino e mi portino oltre i luoghi comuni, nei quali invece tutto si mescola e nulla si distingue, e non è affatto in una mescolanza indistinta che avviene la fusione e compenetrazione della Lila, la sofferenza del passato che viene rivissuta dev’essere qualcosa di reale, che esiste ancora e basta solo evocare, e che va controllata affinché non si ripeta o non sfugga al controllo. C’è tanto da esplorare.
Leggo così, in fretta, avido di pormi domande e curiosità che se vorrò poi davvero soddisfare, dovrò lasciarmi guidare dalla pazienza e dalla calma. L’origine della musica, degli strumenti, dei suoni, rinvia alla particolare e complessa ritualità sciamanica Gnaoua, di cui è parte integrante. I rituali di possessione e guarigione, la lunga notte, la Lila, che fa da incubatrice, dove tutto avviene, riemerge insieme e insieme i partecipanti si compenetrano. Non so quasi nulla di queste cose, cerco di registrare indizi che mi spieghino e mi portino oltre i luoghi comuni, nei quali invece tutto si mescola e nulla si distingue, e non è affatto in una mescolanza indistinta che avviene la fusione e compenetrazione della Lila, la sofferenza del passato che viene rivissuta dev’essere qualcosa di reale, che esiste ancora e basta solo evocare, e che va controllata affinché non si ripeta o non sfugga al controllo. C’è tanto da esplorare.
Il festival dedica anche ampio spazio alla riflessione e all’analisi, alla conoscenza e al confronto. L’edizione di quest’anno dedica un forum specifico al tema della diaspora africana. Il titolo è Radici, mobilità, ancoraggi. Tutti i viaggiatori hanno bisogno di ancoraggi, soprattutto quando il viaggio è obbligato e necessario e non è scelto come un sogno di vacanza, come per noi, o come anni fa degli amici tedeschi con cui collaborai ad un bel progetto di intercultura intitolarono un’interessante attività. E poi la musica, questa musica che si lancia alla conquista del mondo, di un mondo da decifrare di nuovo e che ogni giorno è qualcosa d’altro, e porta qualcosa d’altro, da altre tradizioni e storie. Tra gli artisti l’americano Christian Scott accanto al marocchino Maalem Hamid el Kasri, Rachida Talal e tanti altri. Sono diversi i palchi allestiti, il principale nella piazza Moulay Hassan, e poi un altro sulla spiaggia, battuta dal vento ma non disertata, e altri ancora, su un torrione o in altre piazzette. Fiumi di gente che fa la spola avanti e indietro, tra i palchi e i vicoli della città.
Il festival forse va oltre la stessa tradizione da cui nasce, e va oltre la sua città, Essaouira. Ed Essaouira va oltre il suo festival, lo incorpora. La musica la incontri in ogni locale, la città vive in simbiosi con questa musica, in diversi laboratori puoi vedere artigiani che fabbricano strumenti musicali, scaldano le pelli dei tamburi, ci disegnano mani o altri elementi usando l’hennè. Nelle piazzette che si alternano ai vicoli incontri gruppi di musicisti, di 4 o 5 persone, con i grenbì e i crotali, ma anche altri, più numerosi, delle vere compagnie, come confraternite che girano, oppure suonatori ambulanti da soli o più spesso a coppie.
Essaouira sembra una fiera, è un mercato diffuso ovunque, un bazar all’aperto, con i suoi multiformi oggetti, le borse di pelle, i tessuti di lino, i prodotti dell’argan, gli anelli e i bracciali, gli strumenti musicali della tradizione, gli oggetti dell’artigianato, antichi o ripetuti o anche imitati oggi per il consumo dei turisti, tanti ma non così numerosi. Oggetti dell’artigianato attraverso cui guardare, come oltre uno specchio, storie più lontane, se ancora si riesce a intravederle, o a decifrarle. I mercati sono contenitori di ricordi da valutare e barattare, tracce di memoria in cui ritrovarsi e da ricercare ovunque nell’intrico dei vicoli, veri corridoi aperti sotto l’azzurro denso del cielo.
Azrak, è in Salento che ho trovato questa parola, che mi dicevano di origine araba, per indicare l’intensità del cielo. Sono di nuovo qui e per orientarmi cerco di aiutarmi con quelli che credo siano i miei riferimenti, per gustarmi meglio, credo, questa fiera in cui ci aggiriamo. Ovviamente, sono molti anche i ristoranti, di cui apprezziamo i sapori e le atmosfere, senza perderci nessuna delle variazioni possibili del tajine. Sempre piacevolmente immersi dentro un’umanità assai multiforme, diffusa anche nelle tarde ore della notte. La Lila, un’incubatrice che non taglia ponti ma rievoca antiche sofferenze, per controllarle, tutti insieme, e non subirle ancora. Da quanto tempo, mi chiedo, le strade delle nostre città si sono svuotate, e ciascuno è solo? Se lo isoli lo metti sotto cura, dicevo più sopra, lo disarmi. Le strade qui sono un via vai continuo di gente del posto, e anche di tanti altri da diversi paesi lontani, tra i tanti anche noi turisti, che fingiamo d’essere viaggiatori mentre raccattiamo qua e là impressioni da riutilizzare, comunque, al meglio.
 Ritorniamo indietro passando di nuovo da Marrakech, un altro iperspazio, ancora più totalizzante. Qui forse, scusate il gioco di parole, è un’antropologia massimalista quella che ci servirebbe: chissà quali stratificazioni sociali vi sono sedimentate sotto, e in quali forme, quali configurazioni di potere? Al centro c’è la piazza, nella sua variegata vivacità di voci e suoni che si sovrappongono. Anche qui tra i tanti strumenti ci sono grenbì e crotali. C’è un ragazzo con il suo cerchio di persone attorno, che suona tutto da solo, nel senso che da solo suona la chitarra, una sua batteria, canta e quando non canta suona anche l’armonica. Ha addirittura un intero set di armoniche, che cambia a seconda della canzone. Scopriamo che è italo marocchino, ha la madre italiana ed è cresciuto in Italia, poi è partito per il nord Europa, prima di venire in Marocco. Radici, mobilità e ancoraggi, in chiave moderna. È un nostro concittadino, insomma. Dialoga con noi attraverso il microfono, pubblicamente, e poi traduce in arabo per i presenti, quasi una piccola conferenza. Ci canta e suona alcune canzoni italiane. È bravo, non è improvvisato il suo spettacolo. Ci fa ascoltare anche un meticciato musicale italo marocchino arrangiato da lui, chissà come gli è venuto in mente, l’arrangiamento è nuovo e la canzone sembra un’altra, si tratta di “io sono un italiano” di Toto Cotugno: dove è qui il confine tra tradizione e modernità? Mi arrendo, siamo davvero in un altro iperspazio. Chiude la serie di canzoni per noi con una sua composizione, non è solo compositore è anche autore, qui oltre alle musiche ha riarrangiato anche il testo. Le parole cantano di un’Italia corrotta e di parlamentari che pensano solo a se stessi e di giovani italiani che partono per altri paesi d’Europa. La mia battuta è: toh, porta l’Italia nel mondo! Nel ritornello ricorre una domanda “chi ci rappresenterà?” Tutto questo dopo il festival di Essaouira e appena la sera prima del rientro vero a casa, in una piazza Jāmiʿ el-Fnā gremita di gente. Siamo davvero internazionali.
Ritorniamo indietro passando di nuovo da Marrakech, un altro iperspazio, ancora più totalizzante. Qui forse, scusate il gioco di parole, è un’antropologia massimalista quella che ci servirebbe: chissà quali stratificazioni sociali vi sono sedimentate sotto, e in quali forme, quali configurazioni di potere? Al centro c’è la piazza, nella sua variegata vivacità di voci e suoni che si sovrappongono. Anche qui tra i tanti strumenti ci sono grenbì e crotali. C’è un ragazzo con il suo cerchio di persone attorno, che suona tutto da solo, nel senso che da solo suona la chitarra, una sua batteria, canta e quando non canta suona anche l’armonica. Ha addirittura un intero set di armoniche, che cambia a seconda della canzone. Scopriamo che è italo marocchino, ha la madre italiana ed è cresciuto in Italia, poi è partito per il nord Europa, prima di venire in Marocco. Radici, mobilità e ancoraggi, in chiave moderna. È un nostro concittadino, insomma. Dialoga con noi attraverso il microfono, pubblicamente, e poi traduce in arabo per i presenti, quasi una piccola conferenza. Ci canta e suona alcune canzoni italiane. È bravo, non è improvvisato il suo spettacolo. Ci fa ascoltare anche un meticciato musicale italo marocchino arrangiato da lui, chissà come gli è venuto in mente, l’arrangiamento è nuovo e la canzone sembra un’altra, si tratta di “io sono un italiano” di Toto Cotugno: dove è qui il confine tra tradizione e modernità? Mi arrendo, siamo davvero in un altro iperspazio. Chiude la serie di canzoni per noi con una sua composizione, non è solo compositore è anche autore, qui oltre alle musiche ha riarrangiato anche il testo. Le parole cantano di un’Italia corrotta e di parlamentari che pensano solo a se stessi e di giovani italiani che partono per altri paesi d’Europa. La mia battuta è: toh, porta l’Italia nel mondo! Nel ritornello ricorre una domanda “chi ci rappresenterà?” Tutto questo dopo il festival di Essaouira e appena la sera prima del rientro vero a casa, in una piazza Jāmiʿ el-Fnā gremita di gente. Siamo davvero internazionali.
(Guarda QUI le foto dell’amico Giacomo Scattolini)